| |
Balestra deriva dal latino Balista. Arma
formata da un arco fissato ad un fusto di legno e da un dispositivo atto
a tener ferma al fusto (teniere) la corda, una volta tesa, e a
farla scattare al momento opportuno per lanciare un dardo. L'arco della
Balestra è normalmente d'acciaio, talvolta di legno o di osso o di
corno. Il teniere quasi sempre di legno e talvolta di ferro e di
acciaio, è provvisto di una scanalatura nella quale scorre la freccia
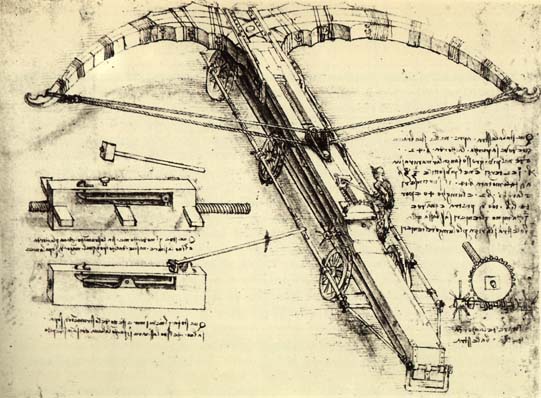 che
da essa è guidata. L'arma comprende: ad una estremità del teniere, una
specie di calcio che il balestriere appoggia alla propria spalla quando
deve mirare; all'altra estremità una staffa o gancio (corona) per
caricare l'arma e per assicurare la balestra al perno del banco. Gli
antichi Assiri, Babilonesi, Greci ed Egiziani, probabilmente conoscevano
le Balestre; ma esse erano certamente note ai Romani. Nel Medioevo la
Chiesa Cattolica (concilio del laterano 1139) vietò l'uso di queste armi
da parte di cristiani contro cristiani, permettendolo solo contro gli
infedeli, ma nel 1198 Riccardo, Cuor di Leone, adottò le Balestre nel
suo esercito. Esse erano di varia grandezza e di varia conformazione, a
seconda dell'uso cui erano destinate. Venivano impiegate da un fante
oppure erano istallate sopra cavalletti o carri per la difesa delle mura
o per la battaglia in campo aperto. Le balestre erano impiegate per
lanciare e, più spesso, frecce pesanti a testa quadrangolare od a
bottone. Venivano altresì usate frecce incendiarie, formate con sostanze
bituminose, accese prima del lancio. Successivamente questi ordigni di
guerra vennero sostituiti dalle armi da fuoco. Oggi la balestra antica
italiana viene usata per manifestazioni storiche quali il palio della
balestra fra le città di Gubbio e Sansepolcro e nella disputa del
campionato italiano fra le cinque città federate, Sansepolcro-Gubbio-San
Marino-Lucca-Massa Marittima. Come arma è inoltre ricercata da
collezionisti e amatori di armi antiche. che
da essa è guidata. L'arma comprende: ad una estremità del teniere, una
specie di calcio che il balestriere appoggia alla propria spalla quando
deve mirare; all'altra estremità una staffa o gancio (corona) per
caricare l'arma e per assicurare la balestra al perno del banco. Gli
antichi Assiri, Babilonesi, Greci ed Egiziani, probabilmente conoscevano
le Balestre; ma esse erano certamente note ai Romani. Nel Medioevo la
Chiesa Cattolica (concilio del laterano 1139) vietò l'uso di queste armi
da parte di cristiani contro cristiani, permettendolo solo contro gli
infedeli, ma nel 1198 Riccardo, Cuor di Leone, adottò le Balestre nel
suo esercito. Esse erano di varia grandezza e di varia conformazione, a
seconda dell'uso cui erano destinate. Venivano impiegate da un fante
oppure erano istallate sopra cavalletti o carri per la difesa delle mura
o per la battaglia in campo aperto. Le balestre erano impiegate per
lanciare e, più spesso, frecce pesanti a testa quadrangolare od a
bottone. Venivano altresì usate frecce incendiarie, formate con sostanze
bituminose, accese prima del lancio. Successivamente questi ordigni di
guerra vennero sostituiti dalle armi da fuoco. Oggi la balestra antica
italiana viene usata per manifestazioni storiche quali il palio della
balestra fra le città di Gubbio e Sansepolcro e nella disputa del
campionato italiano fra le cinque città federate, Sansepolcro-Gubbio-San
Marino-Lucca-Massa Marittima. Come arma è inoltre ricercata da
collezionisti e amatori di armi antiche.
 |
|